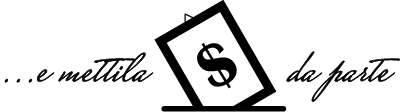All’esposizione ci sono stato questo pomeriggio e posso assicurare che sono stati i 5 euro meglio spesi negli ultimi tempi, sarà anche perché ho un debole per tutti quegli artisti che creano con la loro immaginazione un mondo fantastico e lo riempiono di personaggi straordinari e improbabili ma allo stesso tempo fortemente comunicativi. Penso per esempio a Chagall, del quale aspetto con ansia la mostra di settembre, oppure agli acquerelli e alle ceramiche di un grande maestro come Luigi Ontani, ancora poco valorizzato in Italia.
E poi c’è Takashi Murakami, forse insieme a Yayoi Kusama, il più importante artista giapponese contemporaneo e sicuramente il più quotato visto che la sua opera “My Lonesome Cowboy” nel 2008 è stata battuta a New York da Sotheby’s per 15,2 milioni di dollari. Il mondo di Murakami è sempre stato popolato da fiori umanizzati, animali ibridi e strambi, personaggi che sembrano appena usciti da un fumetto manga, un mondo che deriva dalla tradizionale cultura giapponese e si riallaccia alla storia dell’arte moderna occidentale.
Tutto giapponese è invece il mondo che si apre davanti ai nostri occhi nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Protagonisti assoluti sono gli “Arhat” che secondo la tradizione buddista sono persone che hanno percorso lo stesso cammino di un Buddha raggiungendo così il Nirvana. E si rimane affascinati ad osservare sulle quattro tele enormi questi vecchi definiti Santi, illuminati, ma che dalle espressioni dei loro volti o dai loro atteggiamenti tutto comunicano fuorché saggezza. Sembra quasi che il Nirvana sia per l’artista una viaggio dentro e oltre la follia, in un limbo psichedelico pieno di colori e di simboli tanto affascinanti quanto di difficile interpretazione, almeno per noi occidentali. Cosa sta a significare per esempio l’albero che esce dalla testa della pecora in una delle tele gigantesche o dalla testa dell’autoritratto dell’artista stesso in un altro dipinto?
Si potrebbe stare ore davanti a queste tele e non si finirebbe di cogliere particolari nuovi e interessanti. L’occhio si perde se lasciato scorrere libero sugli sfondi, creati ogni volta con fantasie diverse, vuoi con pallini che vanno a formare raggi colorati, o triangolini che sfumano e prendono i colori dai personaggi che sfiorano. Poi ci sono i teschi, che tutto sembrano fuorché simboli di morte.

Insomma un Takashi Murakami diverso e forse più profondo è quello che ci viene presentato da Francesco Bonami a Palazzo Reale. Un artista che si confronta con il disastro provocato dal terremoto e dallo tsunami di Fukushima del 2011 che ha scosso e cambiato il popolo giaponese e di conseguenza l’arte di Murakami.