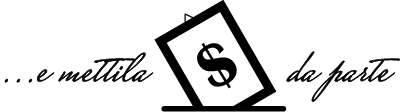Eppure, 500 anni dopo la loro creazione, un altro artista è riuscito ad aggiungere ancora qualcosa a questi capolavori: il respiro, il sangue, la vita.
Come ci è riuscito?
Ovviamente non ha violato il marmo scolpito dal grande maestro, ma è riuscito nonostante tutto a far emergere tutti i segreti della materia attraverso il mezzo artistico per eccellenza del ‘900: la fotografia. E lui, al pari di Michelangelo, è un maestro del nostro tempo. Si chiama Aurelio Amendola ed è famoso per essere il fotografo degli artisti. In tanti hanno voluto essere immortalati esclusivamente da lui, da Alberto Burri a Renato Guttuso, da Giorgio De Chirico a Roy Lichtenstein. Poi Jannis Kounellis, Mario Schifano, Mi
Tutti questi scatti si possono ammirare alla mostra “In Atelier – Aurelio Amendola: fotografie 1970-2014” allestita alla Triennale di Milano in collaborazione con l’Università IULM. Tutte immagini bellissime che mettono l’artista, il più delle volte ripreso nel suo atelier nel bel mezzo della creazione artistica, a nudo davanti ai nostri occhi riuscendo a mostrarci il suo carattere e la sua più vera personalità.
Tra tutte queste immagini, quelle che mi hanno colpito maggiormente comunque, non sono quelle appese alle pareti, ma quelle racchiuse all’interno di un enorme fascicolo riccamente ricamato e posto alla fine del corridoio principale della sala. È lì dentro che sono conservati gli scatti più affascinanti di tutta la mostra: i ritratti delle sculture michelangiolesche delle Cappelle Medicee. E mentre osservi il fondoschiena del David, Il viso di Giuliano dei Medici che ti spia di scorcio da dietro il muro, l’aurora vista di scorcio dal basso, il particolare di una pupilla o la vena sulla mano, riesci a sentire il rintocco dello scalpello del “Divino” sul marmo, il freddo sulla tua mano che tocca l’epidermide della statua, il respiro del personaggio e lo scorrere del sangue nelle sue vene.
Tutta questa magia ottenu